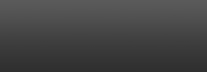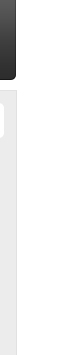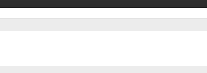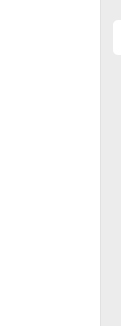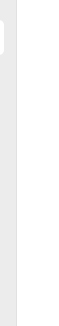Il caso
Nel maggio 2002, A, giovane impiegata di 34 anni, rimasta vittima di un sinistro
stradale è in lista d’attesa presso un ospedale milanese per eseguire in
artroscopia la ricostruzione legamentosa del crociato al ginocchio sinistro; ma
dopo vana attesa, a causa del dolore decide di dar retta a un amico, che le
indica una clinica privata in altra città, dove in giugno viene effettivamente
operata.
L’intervento, apparentemente riuscito, condotto secondo la regola
d’arte, lascia sull’arto inferiore della paziente due vistose e deturpanti
cicatrici, di notevoli dimensioni. La poveretta, cui non era stato evidenziato
il rischio di simili “postumi”, ripugnanti alla vista, cade in depressione, al
punto da cercare di togliersi la vita, abusando dei sedativi che le vengono
prescritti.
A si rivolge al nostro Studio che inizia un penoso
e inutile braccio di ferro con i sanitari e le rispettive compagnie
assicuratrici. Così che, nel 2006 viene instaurato il relativo giudizio avanti
al Tribunale di Milano per ottenere il giusto riconoscimento del pregiudizio (patrimoniale e
non) subito.
La causa è giunta finalmente alla sua conclusione, con la condanna dei responsabili al risarcimento del grave danno biologico e alla vita di relazione derivato alla
paziente in esito all’operato dei sanitari intervenuti.
Al di là di ogni valutazione economica e morale di “equità” o “iniquità”
di un danno siffatto, il presente articolo intende offrire un contributo in
tema di responsabilità medica sotto i profili deontologico ed etico del sanitario in genere e del medico, in particolare, i quali si trovano coinvolti sempre più sovente in
“attività” e “prestazioni” svolte in modo “meccanico”, “non consapevole”, che
rischiano –come nel caso da noi
affrontato- di arrecare importanti pregiudizi alla salute dei cittadini.
Un ulteriore gesto di “allarme”, questo, che non vuole però essere
visto come segnale “passivo”, d’“intolleranza”, ben sì “attivo” e propositivo;
al punto che, se correttamente “compreso” dagli addetti ai lavori possa fungere
da insegnamento per veicolare ogni sforzo ed energia esistenti, da un lato,
verso una maggiore “attenzione” e scrupolo da parte della categoria
medico-sanitaria, dall’altro, verso una sempre maggior “protezione giuridica”
da parte dei Giudici.
Siamo convinti che l’attuale fase di crisi economica globale,
accompagnata soprattutto da una evidente e ben più grave crisi di “valori”
umani, imponga al nostro Studio di accantonare ogni altra implicazione
economica del caso risolto
per concentrare la riflessione sul tema dell’etica comportamentale e della sensibilizzazione
necessaria in ogni campo.
Del mancato consenso
informato
Nel corso della causa, le prove acquisite hanno permesso al Giudice di
accertare -al di là di ogni ragionevole dubbio- che in clinica ad A era stato fatto sottoscrivere un modulo standard,
prestampato, contenente una dichiarazione di “consenso informato”, mentre giaceva
già pre-anestetizzata sul “lettino”, in attesa di entrare in sala operatoria.
A non aveva ricevuto dai sanitari, però –né prima
né dopo-, alcuna informazione del tipo d’intervento cui sarebbe stata
sottoposta, né dei rischi, anche cicatriziali, postoperatori o di altri
possibili postumi residuali.
Solo al risveglio, dunque, dopo l’operazione subita (in anestesia
totale), A si
accorgeva del “disastro” estetico provocatole su entrambi i lati della gamba
infortunata. Quanto bastava per farla piombare nel più nero sconforto. Così,
tra crisi di panico e ansia, A entrava e usciva dal “pronto
soccorso” di vari ospedali, passando, in particolare, dal
reparto di “psichiatria”. E la reazione ansioso-depressiva che ha accompagnato A per anni, finanche esponendola al rischio di
perdere il posto di lavoro -di qui la successiva diagnosi di “disturbo di
personalità” di qui la successiva diagnosi di “disturbo di personalità”-, nonostante
tutto il tempo trascorso (dieci anni circa), è ancora in atto, e confidiamo che
anche grazie al risarcimento ottenuto potrà gradualmente risolversi.
L’episodio concluso, come è deducibile dalla CTU svolta in causa e
dalla condanna finale del Giudice (decisione neppure impugnata dagli stessi
sanitari) fa ritenere che, ove ad A fossero state fornite puntuali informazioni sull’intervento chirurgico
“prenotato”, spiegando le ragioni di un trattamento anziché di un altro e con
linguaggio comprensibile a persona comune, in modo veritiero, e tenendo conto
dell’età e della cultura della paziente, ma soprattutto degli aspetti
psicologici; offrendo una prospettazione “a tutto tondo” dei rischi prevedibili,
come degli esiti cicatriziali importanti; e in forma scritta solo a fini
validanti integrativi e confermativi, dopo un idoneo colloquio medico-paziente
e dopo che il primo si fosse reso conto d’essere stato compreso, la signora A non avrebbe prestato il suo consenso a
quell’intervento.
Nello specifico, infatti, tutti i CTU intervenuti (ben due collegi,
tra cui uno psichiatra, uno psicologo e un chirurgo estetico), hanno
evidenziato al Giudice che le modalità di “raccolta” del “consenso informato” della paziente non erano sufficientemente valide e conclamavano, forse anche, una realtà ben lungi da quella
prospettata.
Rilievi questi che, per quanto interessa il presente articolo,
meritano approfondimento ulteriore, anche alla luce dell’attuale orientamento
della Suprema Corte di Cassazione sul punto.
Della validità del consenso
Va in primis ricordato che, per avere validità, la Cassazione ha da ultimo statuito
che il “consenso” deve possedere determinate caratteristiche o “requisiti” che,
alla stregua delle norme di deontologia medica, possono così riassumersi:-
dev’essere dato in forma espressa dall’avente diritto, di maggiore di età,
capace di intendere e volere e non può mai essere presunto, né fornito da
congiunti del paziente; - dev’essere prestato prima dell’inizio dell’atto
medico; - dev’essere specifico rispetto
al trattamento medico cui si riferisce; - dev’essere consapevole, cioè basato
su una preventiva e completa informazione; - dev’essere libero da errore, da
travisamento dei fatti, tale che se l’avente diritto avesse compreso le notizie
fornite lo avrebbe egualmente connesso; - deve permanere per tutta la durata
del trattamento medico. Per quanto, invece, attiene al corretto comportamento
del medico, esso deve dare al paziente informazioni su diagnosi, prognosi e
prospettive terapeutiche tenendo conto del livello di cultura e delle effettive
capacità di discernimento di esso. L’informazione deve essere serena e
consapevole dei limiti delle altrui conoscenze mediche e finalizzata a promuovere
l’adesione alle proposte terapeutiche. E nei casi gravi, dev’essere data con cautela
e senza mai escludere elementi di speranza.
La forma del consenso è essenzialmente “libera”, purché risulti in
modo espresso l’intenzione dell’avente diritto di sottoporsi a quel trattamento
medico.
E’ certo, quindi, -come nel caso da noi affrontato- che la
sottoscrizione di un modulo standard, prestampato, non consenta di conoscere se
il trattamento sia stato veramente e pienamente inteso dal paziente (n.d.r. nel
nostro caso era incosciente).
Sul punto va perciò applaudito l’approdo “sensibilizzatore” della
moderna giurisprudenza, secondo la quale deve “risultare” con certezza che il
medico abbia “parlato” con il paziente prima di aver eseguito l’ intervento o
attuato una terapia, rendendosi conto d’essere stato compreso. Il caso
analizzato consente però di ritenere “indispensabile” un ulteriore requisito di
validità: il consenso, in caso di
atti chirurgici e di talune procedure invasive di diagnosi o di terapie di
trattamenti oncologici o psichiatrici e altre prestazioni implicanti l’uso di
sostanze di contrasto, per esser “informato” deve essere scritto e descrittivo.